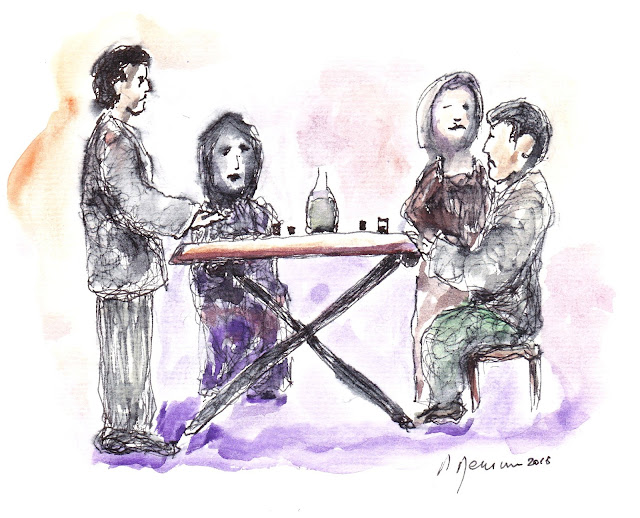|
| Paolo Demuru, "Dante e Beatrice", acquerello, 2016 |
L’altra notte per me è stata piena di
sogni… eh sì, i sogni spesso sono curiosi perché si configurano in auspici o in
ricordi nostalgici oppure sconfinano nella sfera dell’impossibile.
Ero in un luogo a me familiare, che però
non so proprio precisare, e vidi giungere un uomo sulla cinquantina con passo
sicuro e cadenzato; coperto da una vestaglia lunga che gli dava un aspetto
dignitoso e quasi regale. Lo sguardo era meditabondo, l’occhio vivo e
penetrante, la fronte avvolta in un telo colorato e al braccio sinistro tre
libri.
Era accompagnato da una donna elegante e sinuosa, leggera e gentile,
coperta d’un velo bianco e un abito rosso sotto un mantello verde, parlava a
voce bassa e con il sorriso.
L’uomo dal saggio aspetto, parlava poco ma
asseriva assai, concedeva più tempo all’ascolto che alla parola…
Come li vidi avvicinare feci un passo indietro
ma l’uomo al quale pareva che nulla sfuggisse, arrivato di fianco a me voltò lo
sguardo e con voce sensuale e avvolgente mi disse in buon fiorentino:
-Ovvia!, visto che tu t’hai tradotto ’n
gallurese la mi’ Comedìa mettine qualche terzina nel tu’ blog, non si sa mai
ch’altri se ne ‘nnamori, visto che nelle scole m’han quasi dimenticato; oh
quanto mi garba star un po’ tra la tu’ gente, o per meglio dir su la tu’
collina, tra gli amici che tu hai testé celebrato…-
Mentre mi apprestavo timidamente a
rispondere la saggia figura, proferite affettuosamente queste parole, sparì e
così anche quella dell’avvenente
compagna.
Rimasi solo a meditare in un bel viale tra grossi alberi dove una
flebile brezza componeva tra le cime più alte dei pini un lontano concerto di
violini mentre ai lati della pista, tra erici, lecci, lavanda ed elicriso,
vedevo svincolarsi da blocchi di basalto grigio volti che mi apparivano già visti. Però sorpreso mi
chiesi: come? Blocchi di basalto tra i graniti?
Ebbi un sussulto e quasi mi
svegliai. Nel sonno residuo riuscii a ricordare quel saggio e quella bella
dama, di lui ben più giovane che l’accompagnava e conclusi: ma questi forse in
qualche occasione li ho conosciuti e, dovrei assecondare…
22 Eu ghjà vidis’a lu dí
cumincendi
la palti d’orienti tutta ruiata,
e ill’alti
palti sirenu lucendi;
25 e cara di soli pa alzann’umbrata,
cussì
ben’attemparata da umori
e da l’occhj
umanu suppultata:
28 cussì ‘ndrent’a chissa neula di fiori
chi da
man’agnelichi alzà ni duìa
falendi
‘ndrent’e fora mori mori,
31 subbra ‘ candidu telu cinta d’ulia
femina parisi,
suttu ‘eldi mantu
tutta ‘istuta
‘llu culori di fiama ‘ia.
(Purgatorio, canto XXX vv. 22-33)
Paolo Demuru